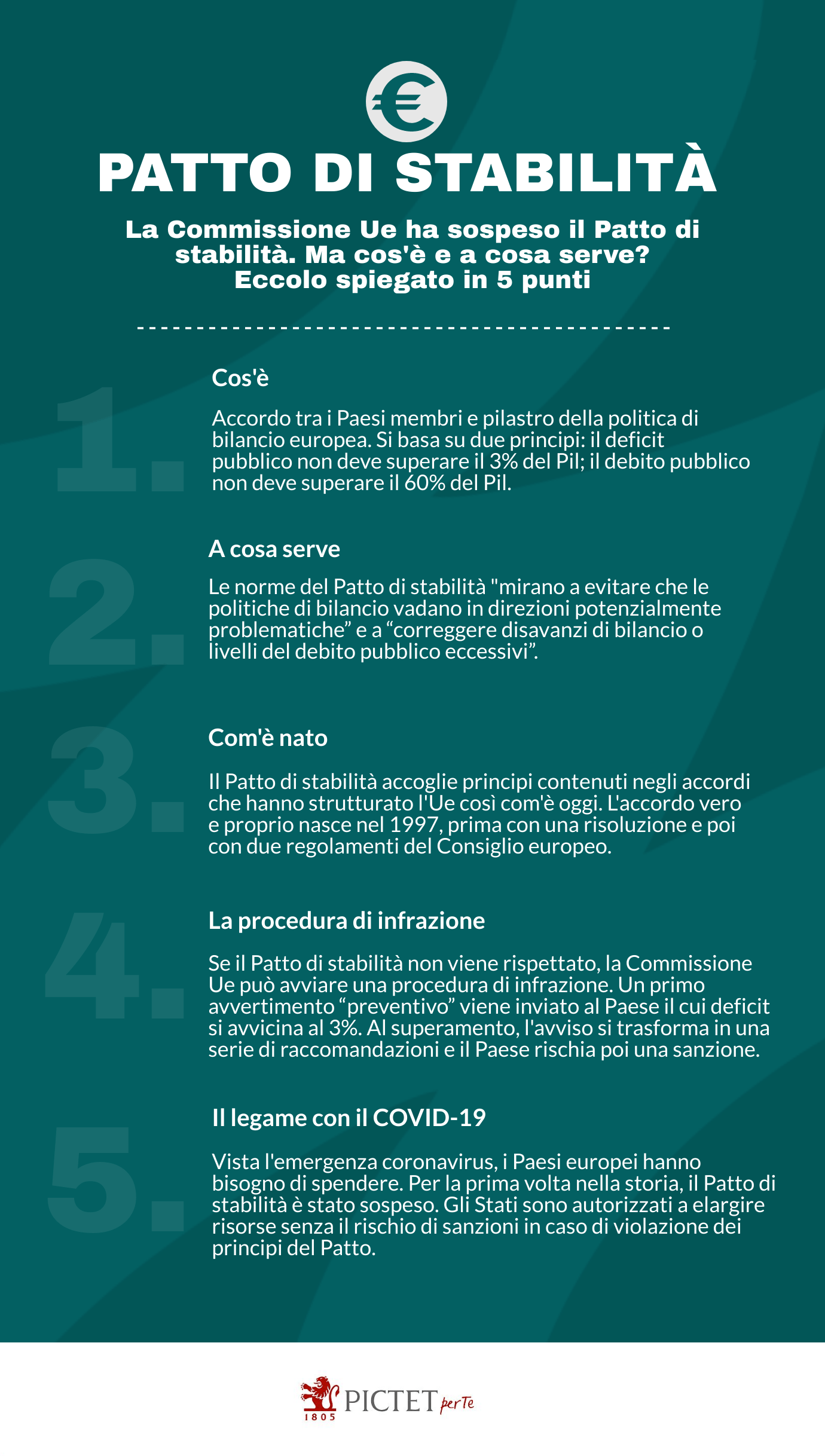E’ stato presentato oggi il rapporto Censis. Come ogni anno, il rapporto approfondisce aspetti della vita sociale e quotidiana degli italiani, attraverso interviste sul campo. Se l’interpretazione che viene fornita dal rapporto può non essere condivisibile, i dati che provengono dalle interviste sono spaccati della vita reale del Paese che non possono essere ignorati.
Nell’insieme, il quadro che emerge da questi dati è, a mio parere, quello di un Paese in preda alla paura che chiede protezione e sicurezza, anche al costo della libertà e di certi diritti. Il sentimento prevalente, in oltre il 73% degli intervistati, è la paura per il futuro. Questo è il dato di fondo, dal quale bisogna partire per spiegare tutto. In una società impoverita già in forma strutturale da anni (il reddito netto medio da lavoro dipendente di una famiglia di 3 persone al netto dell’inflazione diminuisce, fra 2003 e 2017, di circa 6 punti percentuali, ci dice l’Istat) e con una sensazione crescente di insicurezza anche in termini di ordine pubblico (sempre secondo l’Istat i cittadini che dichiarano di vivere in una zona ad alto rischio di criminalità crescono di 12 punti percentuali fra 2008 e 2016) si innesta l’effetto dirompente generato dalla crisi pandemica.
La società italiana si risveglia nel mezzo di un incubo prodotto da uno dei danni più gravi di quasi 30 anni di neoliberismo, ovvero la contrazione dell’offerta sanitaria pubblica, nel pieno della prima epidemia di grave livello dai tempi della spagnola, ed è un risveglio durissimo: spazza via le fragili illusioni di ripresa economica e occupazionale da “austerità” smerciate in questi anni dai cantori della cosiddetta austerità espansiva, accumula nuove diseguaglianze, che potremmo chiamare “pandemiche”, a quelle già presenti da anni e orami sistemiche: disparità nuove fra chi ha il posto fisso e chi no, nell’ambito del primo gruppo fra chi ha il contratto collettivo rinnovato e chi no a causa della paura delle imprese di vedere lievitare i loro costi, e del secondo fra chi ha un’attività legale e chi vive di lavoretti in nero, fra chi accede all’istruzione, anche a distanza, e chi non ha i mezzi, anche informatici, per accedervi, fra chi ha la garanzia delle migliori cure mediche in caso di infezione e chi no. Fra chi vive in un’area del Paese colorata in un modo da consentirgli un minimo di movimento per tentare di trascinare da qualche parte la sua disperazione e chi no.
Nel mezzo di questo incubo, la constatazione più amara è quella della solitudine: a livello macro, lo Stato non riesce ad andare oltre una miserrima carità da risulta, peraltro distribuita male e in grave ritardo, l’Unione Europea si lacera in penose liti da cortile fra frugali e spendaccioni, con i suoi mirabolanti investimenti che si allontanano ogni giorno di più.
A livello meso, la crisi dei corpi intermedi della rappresentanza, anch’essa smerciata come un presunto ammodernamento, come un affrancamento dell’individuo rispetto alla presenza soffocante e paternalista del sistema dei partiti e dei sindacati, dal portato individualistico tipico del neoliberismo, con le sue grancasse mediatiche (non ultima l’esaltazione folle dell’individualismo politico dell’uno vale uno grillino) lascia l’individuo libero di urlare al deserto la sua disperazione, senza più nessuno che raccolga la sua voce.
A livello micro, la famiglia, che in questi anni ha garantito una rete di protezione sociale che lo Stato non riusciva più a garantire, già afflitta da tendenze centrifughe di ogni tipo (da stili di vita ostili alla famiglia fino alla carenza di servizi di sostegno) si lacera in convivenze forzose imposte dai lockdown e vede allontanarsi e dilaniarsi i legami fra le generazioni, con i vecchi, spesso e volentieri supporto economico dei più giovani, che, “per il loro bene”, causa Covid, finiscono isolati.
Il mix dirompente fra paura, insicurezza e solitudine che, già da prima della pandemia, stava stritolando la società italiana, alimentato da impoverimento, crollo del welfare pubblico, sbriciolamento delle istituzioni rappresentative, nonché dagli effetti in termini di identità e di ordine pubblico dell’immigrazione incontrollata, ha avuto all’improvviso una repentina accelerazione per effetto della drammatica sfida lanciata dal virus ad impalcature collettive e fiduciarie collettive pericolanti.
E come stanno reagendo gli italiani? Cosa ci dice il Rapporto Censis sulla loro reazione? La reazione è quella di una società culturalmente stanca, con una psiche collettiva affollata da troppi problemi insormontabili di una quotidianità divenuta troppo insostenibile per riuscire a guardare oltre la superficie del mare nel quale si affoga, ma è soprattutto la reazione di una società egemonizzata da una cultura di ceti medi, di colletti bianchi, educata allo scambio fra disciplina ed obbedienza all’ordine costituito e benessere che è stato alla base del patto sociale degli anni di crescita rapida e sviluppo della seconda metà del novecento. Dominata da un concetto di responsabilizzazione personale in luogo di quella collettiva generato da quasi quarant’anni di atomizzazione neoliberista. Istruita ad anteporre bisogni personali edonistici ad esigenze collettive primarie nel nome di un mito semi-eroico dell’individuo che, con la sua volontà e la sua intraprendenza egoistica può, alla fine del suo sentiero di solitudine, arrivare a costruire dal basso la società dei giusti.
Un popolo così educato non può capire il senso dell’azione collettiva, non riesce ad entrare nella logica di una lotta comune come veicolo per meglio rappresentare i propri interessi. Ecco allora che, come riproducono i dati del Censis, preferisce spaccarsi lungo la linea di faglia del tutto artificiosa fra presunti “privilegiati” con il “culo al caldo” e presunte vittime: l’85,8% degli intervistati pensa che la “vera disparità” in Italia è fra chi ha il posto garantito e chi no, non fra capitale e lavoro.
Un popolo così educato non riesce ad animare un movimento di protesta di lungo periodo: i primi fuochi di paglia di una protesta sociale, peraltro in larga misura eterodiretti da strane ed inquietanti presenze di estrema destra o malavitose, si sono subito spenti, portando avanti un messaggio di spaccatura del fronte sociale, come se i nemici fossero i lavoratori dipendenti e non élite economiche e politiche convertite al neoliberismo.
Un popolo così educato si rifugia in un atteggiamento difensivo: la convinzione che lì fuori non ci sia nessuno ad aiutare porta, ad esempio, ad una crescita della propensione al risparmio che, sottraendo risorse al circuito della domanda aggregata, peggiora gli effetti della crisi. Il 66% degli intervistati sta risparmiando, oltretutto in liquidità e depositi bancari, disinvestendo dal mercato mobiliare e da quello immobiliare.
Un popolo così educato non sa cosa farsene delle “libertà” formali e dei diritti civili garantiti dal neoliberismo, perché tali libertà sono spesso inessenziali, non di rado si traducono in superficiale civetteria da denunce di carta sui social o in edonistiche soddisfazioni che si possono tagliare in momenti di grave crisi: il 57,8% è disponibile a veder comprimere la propria libertà di movimento e riunione in nome dell’emergenza sanitaria. Addirittura, il 38,5% è disponibile a farsi comprimere i propri diritti civili, ma anche quelli politici e sindacali, in cambio di maggiore sicurezza reddituale e lavorativa.
E si guardi bene: non è un atteggiamento da “Paese anziano”. In nome dell’invecchiamento demografico si stanno giustificando troppe cose: in realtà, le due percentuali sopra illustrate salgono, rispettivamente, al 64,7% ed al 44,6% per i giovani fra 18 e 35 anni di età. Sono i giovani, quelli che vivono la maggiore insicurezza esistenziale, ad essere maggiormente disposti a vedere comprimere i propri diritti.
Alla faccia dei libertari da social che soffiano su rivolte per presunte libertà che interessano a pochi, ed alla faccia dell’ideologia delle Sardine, che rappresenta solo un piccolo segmento di giovani relativamente (anche se non sempre) più tutelati per la classe sociale di appartenenza, le giovani generazioni, che non hanno conosciuto gli anni dello sviluppo del benessere e della democrazia, sono cresciute dentro un sistema che comprimeva la più importante delle libertà: quella di avere un futuro. Per cui, di fronte a questa libertà negata, possono anche sacrificarne altre meno rilevanti, pur di vedersi assicurare quel futuro di serenità tanto sognato.
Ancora una volta, niente di nuovo sotto il sole: nel 1922, in un’altra fase drammatica della storia del Paese, i ceti medi in crisi furono disposti, insieme a strati del sottoproletariato, a convergere sugli interessi della borghesia che si addensavano attorno ad una dittatura dai connotati fortemente paternalistici e “protettivi”. Il corporativismo fascista apparve ai più come una forma di regolazione che consentiva, una volta rinunciato alla libertà di espressione, di avere la zuppa sul tavolo tutti i giorni.
Una dittatura paternalistica deve avere anche connotati fortemente giustizialistici: ecco che, non tanto a sorpresa, emerge un lato forcaiolo negli italiani: il 44% è a favore della reintroduzione della pena di morte; tale percentuale arriva al 45% per i più giovani, che in condizioni “normali” immagineremmo più tolleranti degli anziani. Ma non è più così. Ancora una volta, dove la paura morde più dolorosamente, l’insicurezza è maggiore, la rabbia accumulata è più profonda, ed è più diffuso il riflesso di una giustizia più dura e violenta, che dà un falso senso di protezione, e di una giustizia vendicativa, nel tentativo (vano) di placare la propria rabbia.
Il terreno sociale, e questo è un ammonimento molto serio per le classi dirigenti, è pronto per accogliere una dittatura con forti connotati paternalistici e personalistici. La fiducia verso tutte quelle istituzioni che, nell’immaginario liberale, sono i presidi dell’attuale sistema, è ai minimi storici. Neanche il 30% degli italiani, secondo le indagini di Eurobarometro, ha fiducia nell’Unione Europea. Ma attenzione, a beneficio degli euro-exit: la fiducia nelle istituzioni nazionali (Governo e Parlamento nazionali) è altrettanto bassa, se non addirittura inferiore. In altri termini, non c’è un effetto “britannico” di ritorno verso la casa-madre nazionale, c’è un indistinto disprezzo verso qualsiasi istituzione, un fastidio anarcoide verso ogni forma di potere, che apre la strada a soluzioni fascistoidi, perché il nucleo del fascismo storico è esattamente il disprezzo verso le istituzioni tutte, dalla Società delle Nazioni fino al Parlamento, in nome dell’Uomo della Provvidenza che cancelli tutte queste cose, viste come baracconi, e le sostituisca con il suo comando, inflessibile e giustizialista (quando punisce gli altri) e provvidenziale, consociativo ed assistenzialista (quando si rapporta a noi).
La casa non corre il rischio di bruciare in una lunga fase di lotte di piazza, che non stanno più dentro l’immaginario della maggior parte degli italiani, ma più probabilmente nella presa del potere per vie democratiche di un gruppo sufficientemente determinato a dare la spallata finale a ciò che resta della casa stessa, sostituendola con un governo autoritario, magari solo apparentemente costituzionale. Il popolo che aspetta l’uomo provvidenziale ha già venduto in anticipo la sua democrazia.